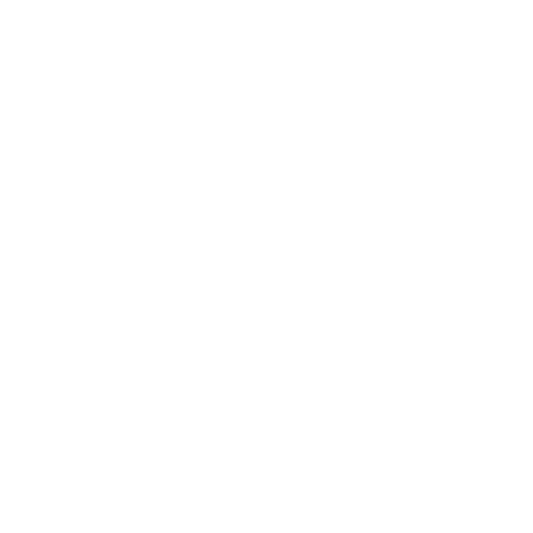Non si muore come si è sempre morti…
La morte, come ogni cosa, ha una sua storia.
(I.S. Allievi, L’ultimo tabù: individuo e società di fronte alla morte, in Sociologia della salute, a cura di M. Bucchi-F. Neresini, Milano, 2011)
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.
Cesare Pavese, 1950
Il Covid-19 ha messo l’umanità intera di fronte al tema della morte, in maniera chiara e prepotente. Non la morte come un nemico lontano, invisibile, quasi inesistente ma la morte come entità ben presente e che, con violenza, si è affacciata alla soglia delle case e dentro la vita di molte persone. Una condizione mai vista prima nella storia. Un organismo invisibile, il coronavirus, ha messo tutto e tutti in ginocchio.
Il Codice Deontologico degli Infermieri dedica un articolo alla morte o, come è definito, al fine vita.
L’art. 24 (Cura nel fine vita) recita così: “L’infermiere presta assistenza fino al termine della vita della persona assistita. Riconosce l’importanza del gesto assistenziale, della pianificazione condivisa delle cure, della palliazione, del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale. L’infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento della persona assistita nell’evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella fase dell’elaborazione del lutto”.
Forse mai prima d’ora come in questi ultimi mesi, perlomeno negli ultimi 70 anni, la professione infermieristica ha dovuto confrontarsi e mettere in atto quanto contenuto in questo articolo. E confrontarsi troppo spesso con la morte delle persone assistite e con i temi ad essa connessi, quali, ad esempio, la dignità della morte e del morire, l’umanizzazione della morte e l’assistenza al morente.
E mai prima d’ora, all’interno di una società che cerca in ogni modo di dimenticare e far dimenticare che esiste la morte, la morte è stata così vicina all’uomo nella vita di tutti i giorni. Sapere di dover morire incute timore, anche se nulla è più naturale della morte. E forse è proprio da questo timore che è nato il “tabù” della morte e di tutto ciò che l’accompagna. La morte, dunque, è diventata un “tabù” innominabile.
Eppure cotidie morimur.
In questi ultimi mesi sono morte tantissime persone, molte delle quali in completa solitudine, con a fianco un infermiere ma senza poter dare un ultimo saluto a una moglie, a un marito, a un compagno, a un figlio, a un amico. Questa è la tragedia nella tragedia. Migliaia di persone che hanno dovuto affrontare la propria morte senza la presenza delle persone care, dei sacramenti e del funerale.
Le sale di rianimazione, e il loro sforzo tecnologico, costringono e condannano all’isolamento e alla solitudine il malato, che si trova solo nel momento della morte, dove macchine e persone si incontrano per l’ultima volta.
Allora, è utile pensare alla morte?
Epicuro afferma che “quando siamo noi, non c’è la morte e quando c’è la morte, non siamo più noi. Nulla dunque essa è per i vivi e per i morti, perché in quelli non c’è, e questi non sono più”. Blaise Pascal, invece, sottolinea che, “benché sia più facile accettare la morte senza pensarci che pensare alla morte, la grandezza dell’uomo consiste proprio nel poter pensare ed essere cosciente di ciò che vive. L’uomo è solo un debole giunco della natura; ma è un giunco pensante. Anche se l’universo lo distrugge, l’uomo è assai più nobile di ciò che lo uccide perché sa di dover morire; l’universo non è affatto consapevole del vantaggio che ha su di lui. Quindi tutta la nostra dignità consiste nel pensiero”.
Se dunque è importante acquisire consapevolezza di cosa è vivere, ancor più è importante acquisire una consapevolezza profonda di cosa significa morire. E questo perché una molecola, un microorganismo incapace di vivere se non come parassita, ha mostrato all’uomo quanto sia ben facile morire. Negli ultimi anni si è tanto parlato del tema della dignità del morire (basti pensare alla legge 219 del 2017, in tema di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, e i numerosi dibattiti, convegni, tavole rotonde che l’hanno preceduta e che si sono succeduti), senza tuttavia riflettere abbastanza sul fatto che il primo approccio al tema è proprio nel pensare alla morte in maniera adeguata. Il filosofo Martin Heidegger insegna che questa “adeguatezza” la si realizza prima di tutto smettendo di parlare della morte in maniera impersonale, come un qualcosa che riguarda qualcun altro. “Si muore”; ma mai: “io muoio”. E dunque la morte diventa una sorta di non realtà per nessuno. Ma se è inevitabile morire, è essenziale morire bene. Il contesto morale in cui si muore è importante.
Occorre, allora, sapere elaborare una vera e propria etica della morte. Assistere la persona che sta morendo è un qualcosa di paradossale perché l’infermiere deve, per quanto possibile, impegnarsi nella relazione d’aiuto e avere anche la capacità di disimpegnarsi emotivamente nella prospettiva di trovarsi, breve, di fronte alla morte del proprio assistito. Ed essere in grado, dunque, di saper affrontare la grande contraddizione: fornire conforto al morente e comprenderne la morte. Qui, la relazione con l’assistito ha un significato e una dimensione che non si trovano in nessuna altra relazione. La relazione con l’assistito, nella fase terminale della vita, diventa quasi il rapporto con la propria morte. Occorre saper assistere la persona nel momento della sua morte, consapevoli di essere mortali.
Ecco che, allora, la fine della vita diventa non un tema, ma il tema fondamentale dell’esistenza di ogni persona, non solo per l’assistito ma anche per il curante, perché investe e coinvolge la radice stessa del rapporto che il curante stesso è in grado di stabilire con sé stesso e con il mondo esterno.
Fino all’alto medioevo, la morte è stata una esperienza familiare e addomesticata. La morte si caratterizzava per la solidarietà tra il morente e la sua comunità. Dall’XI-XII secolo la morte diventa una esperienza più individuale e personale, pur rimanendo incanalata nei riti che permettono di non abbandonarla alla forza ineluttabile e spaventosa della natura. Da qui, l’attenzione crescente all’hora mortis. E’ solo nel ‘900 che la morte diventa un vero e proprio tabù, oggetto di rimozione e di occultamento. La morte diventa un “mero fatto”. E l’uomo scopre la “tanatofobia”, ciò la paura della morte che porta le persone ad evitare ogni pensiero e discorso su di essa. La morte per malattia, oggi la morte per Coronavirus (e/o per le complicanze ad esso associate), è una morte confinata nelle istituzioni (ospedali, terapie intensive, r.s.a.) e la responsabilità della sua gestione è stata delegata in modo pressoché esclusivo ai professionisti sanitari, infermieri e medici.
E’ inevitabile, quindi, che l’accompagnamento al morente e la “cura nel fine vita”, diventino, in questo momento particolare di emergenza sanitaria, un tema centrale per la professione infermieristica.
Il Codice deontologico è chiaro nel richiamare il compito etico dell’infermiere nei confronti della persona morente, andando incontro, per quanto possibile alle sue esigenze, anche a quelle di natura psicologica, relazionale e spirituale. E gli esempi recenti non sono mancati. Laddove la scienza e la medicina sono costrette ad arrendersi a e fallire di fronte all’aggressione del nemico invisibile, l’infermiere non si arrende nel prendersi cura sino agli ultimi istanti di vita del morente, cercando di assicurare all’assistito una morte più serena possibile.
Si tratta, insomma, di una “cura che non cura”, ma che assume ugualmente un grande e profondo significato dal punto di vista assistenziale.
Lo stesso Comitato Nazionale di Bioetica ha riconosciuto l’alto valore bioetico di queste cure, che si sostanziano non nella pretesa di poter strappare un paziente alla morte, ma nella ferma intenzione di non lasciarlo solo, di aiutarlo quindi a vivere questa sua ultima radicale esperienza nel modo più umano possibile, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista spirituale. L’attenzione non è più alla malattia, ma al centro c’è l’assistito, il malato, e dunque la persona nella sua interezza. Rimane l’infermiere: la sua professionalità, il suo “esserci”, il suo “prestare assistenza fino al termine”.
Il Covid-19 ha privato i morenti di quei diritti a cui ha fatto riferimento Philippe Aries, parlando di processo di rimozione della morte. Primo fra tutti il diritto, un tempo fondamentale, di conoscere la propria morte, di preparala, di organizzarla. E’ dunque viva e concreta l’immagine della “solitudine del morente”, consegnataci dal sociologo Norbert Elias. Una morte relegata tra le mura degli ospedali, luoghi pensati e progettati per guarire. E si tratta, per molti aspetti, di una “morte negata”.
Scriveva Aries al proposito nel lontano 1975, e le sue parole sembrano attualissime: “La morte all’ospedale non è più l’occasione di una cerimonia rituale che il morente presiede nel mezzo dell’assemblea dei parenti e degli amici (oggi, al massimo 15, n.d.r.). Questa “morte negata” ai tempi del coronavirus ha comportato l’abolizione dei riti tradizionali del lutto. Ancora una volta, all’infermiere il compito di sostenere i familiari e le persone di riferimento della persona assistita nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto. Una perdita a cui non hanno potuto partecipare; una perdita che l’infermiere potrà solo “raccontare”.
E qui “il dolore è totale”, per usare il termine e il concetto utilizzato da Cecily Saunders, infermiera e assistente sociale poi divenuta medico, che così vuole descrivere la multidimensionalità della sofferenza che colpisce il paziente nella fase terminale della vita. A questo “dolore totale” non può che corrispondere, ecco il senso della “Cura nel fine vita”, richiamata dall’art. 24 del Codice Deontologico delle professioni infermieristiche, una “cura globale”, ossia una cura che prevede la totale presa in carico dell’assistito nelle sue molteplici esigenze, con interventi estesi, oltre all’ambito strettamente sanitario, anche a quelli psicologici, relazionali e spirituali, che, per quanto possibile in questi tempi di emergenza e solitudine sanitaria, possano in qualche modo coinvolgere altresì le persone più vicine al paziente morente. Il Codice parla anche di “palliazione”. Palliativo deriva dal latino pallium, il mantello, un oggetto che non ha solo una funzione fisica di protezione ma racchiude in sé un carattere profondamente simbolico in quanto richiama il gesto solidaristico e spontaneo del prestare aiuto a chi si trova in difficoltà.
Il tutto senza dimenticare quanto sostenuto dal Comitato Nazionale di Bioetica nel 1995 laddove si afferma che nell’affrontare le questioni etiche di fine vita occorre evitare di interporre tra noi e chi vive il morire lo schermo delle nostre convinzioni, per quanto giuste si possano ritenere, in modo da rispettare fino in fondo le credenze, la religione e la mancanza di un riferimento religioso, o qualsiasi altro tipo di posizione che la persona che affronta la morte presenta.
Dunque, gli infermieri, e forse solo loro, ai tempi del coronavirus, si sono trovati ad assistere i morenti in maniera smisurata. E come afferma Roberta Sala, “l’infermiere si trova ad affrontare la morte di chi muore e anche quella di chi sta accanto a chi muore, nonché, infine, la propria, ovvero la paura della propria morte che la morte altrui inevitabilmente suscita.
Cosa può offrire la professione infermieristica?
Mi piace riportare le parole di Patrizia Funghi e Pasquale Giuseppe Macrì, contenute nel capitolo dedicato alla “Questione della morte” nel Trattato di Biodiritto diretto da Stefano Rodotà e Pasquale Zatti, in quanto, a mio parere, tratteggiano molto efficacemente alcuni aspetti di quel “gesto di cura” che caratterizza la professione infermieristica. “I morenti hanno bisogno di un amore coraggioso che sappia sostenere sguardi e silenzi di coloro che la malattia ha fornito di sensi speciali, supplementari, che consentono di sentire e di vedere ciò che gli altri, i sani, non sentono né odono. I morenti hanno bisogno di condividere con gli altri il peso della consapevolezza che la vita è per tutti una “malattia mortale”, ma per loro lo è un po’ più degli altri. Dal vivere accanto a chi, suo malgrado, ha dovuto improvvisamente non solo capire ma anche “sentire” che la vita è una corsa a termine, indipendentemente dall’età e dai progetti ancora incompiuti, si imparano cose preziose che, se veramente interiorizzate, come magma di un vulcano in eruzione, in modo irrefrenabile escono dall’esterno della propria mente per diventare “impegno”, traducendosi in azioni formative oppure in presenze di affetto solidale, discreto, rispettoso della volontà di chi non è più come te, perché “sa” di morire. Non dite mai a chi è nell’ombra della propria morte: “Ti capisco!” Non è possibile capire e quelle parole possono trasformarsi, nostro malgrado, in una presunzione che ferisce e che allontana. Occorre invece imparare a costruire un sentiero di condivisione “sfumata, leggera” con chi soffre, dove bisogna essere “nudi”, senza paura di non avere armi, senza timore di ammettere di essere inadeguati. Chi soffre infatti, sa scusare l’impotenza autentica, ma non può spendere inutilmente energie per supportare la nostra debolezza, le nostre paure camuffate con falsi sorrisi sereni, con parole di falsa speranza che feriscono come frecce avvelenate chi sa di dover morire. La speranza è una cosa seria e di difficile acquisizione e non contempla bugie o irrealistiche previsioni vendute come promesse a bambini ingenui. Senza speranza non è possibile vivere, ma nessuno al nostro posto può riempire di contenuti questo fragile “vaso di creta”. Ci sono cose che ognuno deve fare da solo e sopportare il peso di questa solitudine non è alla portata di tutti; non dobbiamo mai avere l’arroganza di credere che possiamo risparmiare a chi muore la fatica interiore del morire, attraverso bugie non richieste e magari non volute”.
di Giannantonio Barbieri
Avvocato del Foro di Bologna, Patrocinante in Cassazione, Master in Diritto Sanitario, Master in Bioetica
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Bibliografia:
Aa.Vv.,Trattato di Medicina Legale e scienze affini, Padova, 1998
Aa.VV., Trattato di Biodiritto, Milano, 2011
Aramini. M., Introduzione alla Bioetica, Milano, 2009
Aries P. Storia della morte in occidente, Milano, 1978.
Comitato Nazionale di Bioetica, Questioni bioetiche relative alla fine della vita umana, 1995
Defanti C.A., Soglie. Medicina e fine della vita, Torino, 2007.
Elias N., La solitudine del morente, Bologna 1985.
Funghi P e Macrì P.G, Obiezioni del medico e del cittadino, in Trattato di Biodiritto, diretto da Rodotà S. e Zatti P., 2011
Mantovani F. voce Morte, in Enciclopedia del Diritto, Milano, 1977
Saunders C., The evolution of palliative care, 2001.
Sala E, Etica e bioetica per l’infermiere, Roma, 2003
Sgreccia E., Manuale di bioetica, Milano, 2007