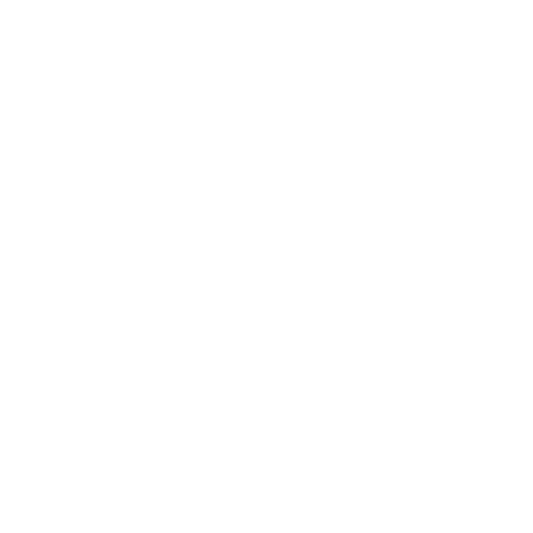(Adnkronos) Una discesa all’inferno. Gli specialisti prendono in prestito l’immagine dei cerchi danteschi per rendere l’idea del percorso dei malati stretti nella morsa delle malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici). Più la patologia resta cronicamente attiva, più il paziente viene spinto giù, da un limbo iniziale fino al vero e proprio inferno. “Fino al danno d’organo. E da qui è difficile risalire e tornare indietro al punto di partenza, nonostante l’aiuto del bisturi”, spiega oggi durante un incontro a Milano Fernando Rizzello, ricercatore del Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche dell’università di Bologna. E’ una parabola discendente che i malati – molti dei quali giovani di 20-30 anni, nel pieno della carriera lavorativa e con famiglia – conoscono bene.
Dolori addominali, spossatezza, sanguinamenti, urgenza di correre al bagno anche più di 10 volte al giorno, le Mici hanno sintomi che tolgono il sonno e spesso anche il lavoro. “Irrompono nella vita sociale e familiare, si insidiano nel rapporto di coppia fin sotto le lenzuola e condizionano la quotidianità – racconta Alessandra Tongiorgi, psicologa dell’Unità operativa di gastroenterologia dell’azienda ospedaliera universitaria Pisana – Persino le vacanze diventano un’impresa”. In una perdita progressiva della qualità di vita se non si spezza il più presto possibile la catena infiammatoria, il ‘fuoco dentro’. Secondo le stime, in assenza di un Registro nazionale e di dati epidemiologici certi, sono circa 200 mila gli italiani colpiti. “Ma il numero è sicuramente sottostimato”, fa notare Rizzello.
“E’ difficile dire a un giovane che deve seguire una terapia a vita – aggiunge l’esperto – Certo, l’avvento dei farmaci biologici ci ha permesso approcci diversi, innovativi. Ma circa la metà dei pazienti non risponde alle terapie e altri se ne perdono strada facendo”. Si registrano sia alte percentuali di mancata risposta primaria (tra il 25 e il 50%), ma anche perdita di risposta secondaria (tra il 30 e il 50%). Proprio per questi pazienti è ora disponibile una nuova opzione terapeutica. Takeda Italia annuncia l’arrivo dell’anticorpo monoclonale vedolizumab, un farmaco biotecnologico a selettività intestinale, approvato per il trattamento di adulti con colite ulcerosa e malattia di Crohn in forma attiva da moderata a grave che hanno avuto una risposta inadeguata, una perdita di risposta, o si sono dimostrati intolleranti alla terapia convenzionale o a un antagonista del fattore di necrosi tumorale alfa.
Il farmaco, che si somministra mediante infusione endovenosa, “ha un innovativo meccanismo d’azione – afferma Silvio Danese, responsabile dell’Ibd Center dell’Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano) – che si basa sull’inibizione selettiva dei linfociti che transitano e vengono reclutati nell’intestino infiammato. I globuli bianchi hanno una sorta di Cap, un codice di avviamento postale che li indirizza e fa sì che vengano attratti per esempio nell’intestino. Per questo particolare sottogruppo il Cap è l’integrina alfa4beta7. Legandosi a essa, vedolizumab blocca solo questi linfociti e l’effetto è di avere una minore tossicità e un’ottima efficacia clinica”.
La richiesta per l’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco è stata supportata dagli studi ‘Gemini’, un programma clinico composto da 4 trial che ha coinvolto circa 3 mila pazienti in quasi 40 Paesi. “Dai dati è emersa la velocità d’azione, che in una buona percentuale di pazienti si ottiene già a 6 settimane dall’inizio del trattamento. E si è osservata anche una riparazione del danno strutturale: più del 90% ha un miglioramento delle ulcere intestinali. La remissione viene mantenuta fino a un anno e abbiamo anche dati nel lungo termine (gli studi si sono prolungati fino a 3 anni) che ci dicono che vedolizumab funziona nel mantenere la risposta del paziente”.
I farmaci biotech, riflette Salvatore Leone, direttore generale di Amici Onlus, l’associazione nazionale per le malattie infiammatorie croniche dell’intestino, “hanno segnato una svolta, un miglioramento della qualità di vita di persone che convivono con una disabilità ‘invisibile’ su cui fanno calare loro stessi un muro di silenzio. Tanto che non viene spesso riconosciuta, soprattutto sul lavoro. I pazienti affrontano un percorso a ostacoli, fin dalla diagnosi che può arrivare con un ritardo anche di 2 anni nel 19% dei casi”.
Un buon rapporto con il medico, con gli infermieri e con il personale sanitario coinvolto nel percorso di cura “è cruciale – continua Leone – Soprattutto se si pensa che, come emerso da un’indagine, ci sono pazienti che interrompono la terapia all’insaputa del medico o che scelgono di non seguirla più per scetticismo verso il camice bianco”. Spesso basta poco a fare la differenza. Un ‘angelo della corsia’, per esempio. Infermieri specializzati che in ospedale “prendono in carico il paziente in sala d’infusione e forniscono non solo un aiuto operativo, ma anche un primo supporto psicologico”, spiega Simona Radice, Ibd Nurse dell’Istituto clinico Humanitas.
“Se si vuole un sistema sanitario sostenibile, la via più efficace non sono certo i tagli sui farmaci – osserva Leone – Bisogna lavorare su altri fattori, sull’aderenza alle terapie, sulla gestione della patologia e sulla diagnosi precoce, oltre a inquadrare le Mici con numeri certi”. Questi malati, sottolinea Tongiorgi, “sono costretti subire limitazioni nella propria vita a causa dei sintomi, sono spesso ostaggio di routine rigide e della necessità di avere un bagno sempre vicino per evitare incidenti particolarmente sgradevoli, magari in un luogo pubblico. Il rischio è di sviluppare un senso di inadeguatezza. Penso a un padre che non può portare il figlio al parco, o alle difficoltà di iniziare una nuova relazione di coppia dovendo confidare all’altro il proprio calvario”.
In questo senso, continua l’esperta, “la possibilità di avere una terapia a disposizione che ha un tempo infusionale estremamente ridotto, e che viene somministrato a regime ogni 2 mesi, permette una pianificazione di una vita normale e può aiutare a migliorare lo stato psicologico e il clima familiare. Ho visto occhi pieni di paura e angoscia in pazienti nei quali i farmaci non funzionavano più, e poi la speranza nel loro sguardo davanti alla possibilità di non tornare di nuovo nel personale inferno quotidiano che si erano lasciati alle spalle”.
Fonte: Adnkronos